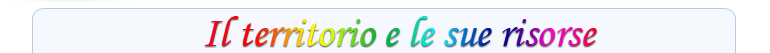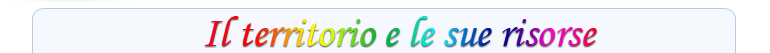RICONOSCIMENTO DELLA DOP, IGP e STG
DOP - Denominazione di Origine Protetta
La DOP nasce (insieme alla IGP) nel 1992 grazie al Regolamento CEE 2081/92 della Comunità Europea, ed è valida solamente per i prodotti agroalimentari (vini e bevande alcoliche esclusi). È quella che impone le norme più stringenti in assoluto, e quindi è quella che garantisce più di tutte la qualità
La DOP offre garanzie su diversi livelli del processo produttivo: origine, provenienza delle materie prime, localizzazione e tradizionalità del processo produttivo.
I prodotti certificati DOP offrono infatti:
- Serietà, in quanto sono prodotti regolamentati da leggi italiane e comunitarie;
- Tracciabilità, poiché i prodotti provengono da una zona geografica delimitata;
- Legame con il territorio, poiché i prodotti sono ottenuti attraverso metodi tradizionali, presentano peculiari caratteristiche dovute ad un intimo legame tra il prodotto ed un territorio con caratteristiche geologiche, agronomiche e climatiche inimitabili;
- Tipicità ovvero rispetto del metodo di produzione tradizionale e dei metodi di fabbricazione che preservano la tipicità del prodotto;
Per poter ricevere l'appellativo devono sussistere due condizioni irrinunciabili, specificate dall'articolo 2 di tale regolamento:
1) Le particolari qualità e caratteristiche del prodotto devono essere dovute, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico del luogo d'origine.
Per "ambiente geografico" la legge intende non solo i fattori naturali ma anche quelli umani, quindi le conoscenze e le tecniche locali.
Una esemplificazione di ciò è la Mozzarella di Bufala Campana, dove gli strumenti utilizzati, l'abillità e l'esperienza dell'operatore, i tempi, le modalità operative, hanno potuto creare un prodotto davvero unico.
2) La produzione delle materie prime e la loro trasformazione fino al prodotto finito devono essere effettuate nella regione delimitata di cui il prodotto porta il nome.
In altre parole: un formaggio DOP deve essere fatto con latte di vacche allevate in zona, così come un salume DOP deve essere ricavato dai suini locali.
Acquistando un prodotto DOP siamo certi riguardo la provenienza degli ingredienti che lo compongono: questa informazione è importante per quei prodotti le cui qualità sono, per un motivo o per l'altro, sensibili a questo fattore, come l'olio extravergine di oliva.
Ogni prodotto DOP, per diventare tale, deve rispettare un disciplinare di produzione che vincola tutte le fasi della produzione e della trasformazione.
Generalmente tutti i prodotti DOP hanno un consorzio di tutela, ovvero un organismo composti da produttori e/o trasformatori aventi come scopo la tutela, la promozione e la valorizzazione dello stesso. Essi hanno anche un ruolo di informazione al consumatore e di vigilanza sulle produzioni. Salvaguardano inoltre il prodotto da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni ed uso improprio della denominazione.
IGP - Indicazione Geografica Protetta
La certificazione IGP è la "sorella minore" della DOP, poiché prevede norme molto meno stringenti rispetto a quest'ultima, che si realizzano in un legame con il territorio molto più blando e con disciplinari di produzione molto più flessibili.
Questa certificazione è molto meno utile rispetto alla DOP poiché, di fatto, nessuna caratteristica importante del prodotto è garantita al 100%. Tuttavia, anche la IGP ha una certa importanza se considerata con cognizione di causa.
Per potersi fregiare di questo titolo un prodotto deve avere le seguenti caratteristiche:
1) Essere originario di tale regione;
2) Una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica;
3) La produzione e/o trasformazione e/o elaborazione devono avvenire nell'area geografica determinata;
Differenze con la DOP
Le differenze riguardano i punti 2) e 3) in quanto mentre la DOP deve avere un forte legame con il territorio, la IGP ne impone uno più blando: è sufficiente che una determinata qualità (e non la qualità dell'alimento) sia attribuibile all'origine geografica.
Al punto 3) troviamo la differenza più importante tra i prodotti DOP e IGP, che rende quest'ultima molto meno efficace per quanto riguarda le garanzie che offre ai consumatori. Infatti nulla ci garantisce riguardo la provenienza delle materie prime, in quanto per ottenere la certificazione è sufficiente che il prodotto venga trasformato o elaborato nell'area interessata. Quindi la certificazione da sola non basta per garantire l'origine delle materie prime, ma occorre conoscere le caratteristiche del singolo prodotto certificato.
Per esempio, le nocciole del Piemonte IGP provengono dall'area geografica determinata (questa caratteristica è imposta dal disciplinare di produzione) e non richiedono una particolare lavorazione: in questo caso l'IGP ne certifica la provenienza. In altri casi questo non avviene, è il caso di un prosciutto che beneficia di una certa fama ed è elaborato in una zona geografica precisa secondo metodi locali, ma con una materia prima proveniente da un'altra regione.
La IGP, quindi, va integrata con conoscenze specifiche riguardo il prodotto in questione.
STG - Specialità Tradizionale Garantita
Accanto alle DOP e alle IGP, la comunità europea ha previsto anche altre certificazioni, che però non hanno riscosso particolare successo a causa della loro eccessiva "genericità" che di fatto le rende inutili in quanto garantiscono ben poco al consumatore. La STG è la più importante.
Questa certificazione nasce con l'obiettivo di tutelare e definire alcune produzioni non legate al territorio, introducendo così il concetto di "specificità" di un prodotto alimentare, ovvero "l'elemento o l'insieme di elementi che distinguono nettamente un prodotto agricolo o alimentare da altri prodotti o alimenti analoghi appartenenti alla stessa categoria".
La specificità delle produzioni viene legata alla ricetta o a particolari metodiche di produzione, e non alla zona di origine anche se viene sempre richiesto un requisito di tradizionalità
Una volta approvato il disciplinare di produzione chiunque, indipendentemente dalla propria localizzazione nell’Unione Europea, aderisca a questo può fregiarsi dell'attestazione di specificità. In parole povere, se esistesse la certificazione STG dei tortellini alla bolognese, un tedesco potrebbe produrli attenendosi alla ricetta tradizionale specificata nel disciplinare utilizzando farina, carne di maiale e formaggio tedeschi. Questo è il motivo per cui questa forma di tutela non ha riscontrato il successo delle DOP e IGP.
Attualmente il formaggio a pasta filata Mozzarella è stato registrato come STG. Il consumatore dovrà quindi abituarsi a distinguere tra il prodotto DOP "Mozzarella di Bufala Campana" e il prodotto "mozzarella STG" che potrà essere ottenuto in Francia, in Germania ed in qualunque altro paese dell’UE. La conseguenza di ciò è che altri produttori europei sono legittimati ad appropriarsi di denominazioni tipiche italiane, facendo concorrenza agli stessi produttori italiani e provocando l'affievolirsi degli stretti legami che da sempre uniscono le denominazioni ai nostri prodotti tradizionali.
Procedure per il riconoscimento della DOP, IGP e SGT
Per conseguire una DOP o IGP o SGT i produttori devono associarsi con un atto pubblico, nel quale tra gli scopi sociali deve essere presente la volontà di registrazione del prodotto.
L'associazione deve allora predisporre uno specifico disciplinare di produzione comprendente il nome del prodotto o alimento, il logo, la descrizione (materie prime, principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche, organolettiche), la delimitazione dell'area geografica, gli elementi comprovanti la provenienza del prodotto dall'area geografica individuata, gli elementi che giustificano il collegamento con l'ambiente geografico, la descrizione del metodo di ottenimento, i riferimenti sulle misure di controllo e gli elementi specifici dell'etichettatura.
La domanda deve essere quindi presentata in bollo al Mipaf, (Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) che entro 30 giorni accerta l'idoneità del soggetto richiedente e controlla che il materiale pervenuto sia esaustivo e completo. A questo punto il Mipaf concorda una riunione con l'associazione richiedente, la Regione e la Camera di Commercio per verificare la rispondenza del disciplinare proposto agli usi locali e costanti previsti dal Reg. CE 2081/92 (per Dop e Igp) e dal Reg. CE 2082/92 (per Stg). Durante questa riunione, se la verifica ha esito positivo, viene preparata la domanda di registrazione corredata della necessaria documentazione, da inviare alla Commissione Europea.
La Commissione Europea procede allora ad un esame formale della richiesta e, nel caso in cui le sue conclusioni siano positive, pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea gli elementi essenziali della domanda.
La pubblicazione vale come notifica della domanda per gli interessati all'accettazione o al rifiuto della stessa. Entro sei mesi dalla data di tale pubblicazione, e qualora non fossero state presentate opposizioni, la denominazione o la indicazione viene iscritta in un registro e l'iscrizione viene notificata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
I Loghi
Con il Regolamento della Commissione europea n. 1726/98 la UE ha adottato un nuovo logo comunitario per identificare i prodotti agricoli ed alimentari i cui nomi sono stati registrati con la Denominazione di origine protetta (DOP) o di Indicazione geografica (IGP).
Questi loghi sono stati realizzati in tutte le lingue e la grafica, identica per entrambe le denominazioni (DOP e IGP), si ispira alle dodici stelle che costituiscono il simbolo dell'Unione europea e mantiene i colori giallo e blu propri dell'Europa.
I Controlli
Dopo l'approvazione dei Reg. n. 2081/92 e n. 2082/92 riguardanti il riconoscimento comunitario dei marchi di qualità, il legislatore italiano è intervenuto in materia di vigilanza, affidando a delle strutture di controllo il compito di garantire che i prodotti certificati rispondano ai requisiti del disciplinare. Inoltre attraverso l'emanazione di vari decreti, dal 1998 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha disposto le modalità con cui devono essere effettuati i controlli da parte dell'Autorità Nazionale competente e le procedure che riguardano l'autorizzazione degli Organismi di controllo privati.
In riferimento all'attività di controllo di ciascuna denominazione, la procedura tecnica da seguire, che comprende tutto il segmento produttivo fino all'immissione al consumo, deve prevedere tra l'altro, accertamenti relativi al controllo:
- dell'origine della materia prima presso le aziende agricole produttrici; - della quantità e della qualità della materia prima;
- della metodologia di trasformazione della materia prima, rispettosa del legame con il territorio;
- del rapporto tra quantità di materia prima avviata alla trasformazione e quantità di prodotto trasformato ottenuto, nell'ambito della zona di produzione;
- della conformità analitica ed organolettica del prodotto ai parametri stabiliti dal disciplinare di produzione;
- dell'etichettatura
|