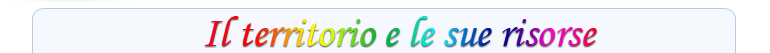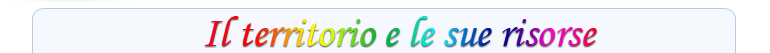OGM IN AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO
La creazione di nuove specie vegetali e animali aiutati dalla chimica
La volontà di migliorare le specie è antica e, nella loro ricerca, l'allevatore e l'agricoltore applicano un metodo ben collaudato. Con molta cura (e tempo!) selezionano una varietà animale o vegetale di cui apprezzano le qualità; tentano poi di migliorarla ulteriormente aggiungendo uno o più caratteri supplementari presenti in un'altra varietà.
Così facendo incrociano dunque due individui di specie date, attenendo pazientemente la discendenza e selezionando l'esemplare dotato di tutte le qualità desiderate. Se si tratta di qualità riguardanti, per esempio, il latte, allevatore potrà giudicare il risultato solo dopo la prima gravidanza dell'animale! Seguirà poi un buon numero di incroci destinati a stabilire la nuova razza: essa infatti dovrà perpetuare senza eccezioni la combinazione di qualità ricercata.
Nel metodo classico, l'incrocio di due individui consiste nel mescolare due scatole nere, continenti ciascuna un insieme di elementi noti, di cui si desidera la riproduzione di elementi sconosciuti potenzialmente indesiderabili; è impossibile prevedere i difetti che la lotteria dell'ereditarietà aggiungerà alle qualità sperate del risultato che si otterrà.
Le tecniche di ingegneria genetica consentono invece di manipolare a piacere (o quasi) il contenuto delle scatole. L'uomo di laboratorio si sostituisce alla cieca ruota della lotteria dell'ereditarietà; egli estrae da una delle scatole l'elemento che determina la qualità richiesta: il "gene d'interesse", e questo solo viene introdotto nell'altra scatola la quale acquista così la potenzialità sperata e, almeno in linea di principio, essa sola.
Le piante transgeniche che si difendono dagli insetti
Grazie all'ingegneria genetica, è possibile dare alle piante la possibilità di difendersi da sole contro gli insetti. Rispetto agli insetticidi tradizionali questa tecnica presenta numerosi vantaggi: non c'è più il rischio del dilavamento dell'insetticida dovuto alla pioggia; vengono distrutti solo gli insetti che attaccano la pianta e questa è protetta fino alle radici. Da una trentina d'anni si utilizzato con successo proteine insetticide derivanti da spore di batteri, come quelle del Bacillus thuringiensis. Queste sostanze permettono di lottare contro i bruchi dei lepidotteri (acari e farfalle). Le diverse tossine provenienti dal B. thuringiensis non sarebbero tossiche per i mammiferi e tuttavia impediscono agli insetti di alimentarsi e riprodursi. I geni codificanti queste endotossine sono stati utilizzati per trasformare piante come il cotone, il pomodoro e la patata; il metodo è stato esteso ad altri insetti, come le dorifore che devastano le piante di patata. Se si tenta di proteggere le piante contro le aggressioni biologiche ( batteri, virus o funghi ) le si aiuta anche a difendersi dallo stress ambientale; è possibile ottenere resistenze ai metalli pesanti, all'acidità del suolo, ai sali, al gelo, all'eccesso di luce, alla radiazione ultravioletta, alla siccità.
L'introduzione di un gene codificante la proteina del pesce, ricca di alanina detta "antigelo", per esempio, rende meno sensibili al freddo piante come le fragole e il tabacco.
Verdure che si conservono meglio e con più nutrienti
|
Altri lavori hanno condotto a modificare la velocità di maturazione, e quindi la conservazione, di frutta o verdura deperibili. Così, dal 1994 la società Calgene commercializza il pomodoro "flavor-save": la durata di conservazione è prolungata e la consistenza rimane intatta.Nel 1996 nei supermercati britannici era possibile trovare passati o concentrati di questo pomodoro transgenico venduto con l'etichetta Sainsbury.Alcuni problemi di salute sono causati dalle allergie; cereali come il riso possono essere fonte di allergeni alimentari: inibendo alcuni geni, si perviene a diminuire i rischi di allergia. |
D'altro canto, poiché il riso è l'alimento base di un terzo della popolazione mondiale, grazie all'addizione di qualche gene potrebbe diventare un alimento ricco di carotene (un precursore della Vitamina A) e di ferro assimilabile, e risolvere così i problemi di carenze vitaminiche (che possono causare, addirittura, cecità) presso numerose popolazioni (in corso di realizzazione).
Quanto agli animali d'allevamento, si cerca di migliorare gli alimenti vegetali, modificandone in qualità e quantità il tenore di amminoacidi e oli. La digeribilità del foraggio migliora aumentando la concentrazione di alcuni enzimi, come per esempio la fitasi. Quest'ultima innovazione diminuisce il tenore di fosfati nelle deiezioni animali e contribuisce a renderle meno inquinanti.
Gli enzimi provenienti dal funzionamento di determinati microrganismi sono correntemente utilizzati nel corso della produzione di numerosi alimenti, come il pane, il formaggio e altri prodotti caseari, la birra, il vino o gli alcolici. Rendere le birre più leggere, favorire la fermentazione del pane, delle olive e del cavolo, influenzare il sapore e la stagionatura dei formaggi: tutto ciò sarà possibile grazie a batteri e lieviti geneticamente modificati. Tuttavia, consumando questi alimenti fermentati si assorbono anche i microrganismi modificati; attualmente la legislazione europea li proibisce, consentendo solo l'utilizzo della produzione purificata di tali OGM (un enzima dovrà così essere estratto dal batterio OGM che l' ha sintetizzato); il DNA batterico non è allora più presente nell'alimento.
|