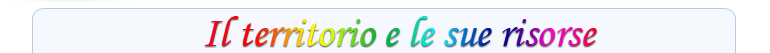Legislazione sugli OGM
Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza
Il Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza è un accordo supplementare alla Convenzione sulla Diversità Biologica, ed è stato adottato il 29 gennaio 2000.
Il termine biosicurezza è ormai entrato a far parte della terminologia comune e viene usato per descrivere l’impegno volto a ridurre ed eliminare i potenziali rischi connessi alle biotecnologie ed ai loro prodotti.
Infatti l’’obiettivo del Protocollo è di “contribuire ad assicurare un livello adeguato di protezione per il trasferimento, la manipolazione e l’utilizzazione sicura degli organismi viventi modificati risultanti dalla biotecnologia moderna che possono avere effetti negativi sulla conservazione e l’uso sostenibile della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute umana, con particolare attenzione ai movimenti transfrontalieri”. A tal scopo si stabilisce una procedura di accordo preventivo dato “in cognizione di causa” al fine di assicurare che i Paesi siano debitamente informati prima di prendere decisioni sull’importazione di tali organismi sul loro territorio. Dal Protocollo sono invece esclusi quegli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) di tipo farmaceutico che sono già disciplinati da altri accordi internazionali.
Nel Protocollo sulla Biosicurezza il termine “moderna biotecnologia indica:
l’applicazione di tecniche in vitro agli acidi nucleici, compresa la ricombinazione dell’acido desossiribonucleico (DNA) e l’introduzione diretta di acidi nucleici in cellule o organiti ,organelli;la fusione cellulare di organismi che non appartengono ad una stessa famiglia tassonomica, che
superano superino le barriere naturali della fisiologia della riproduzione o della ricombinazione e che non rappresentano rappresentino le tecniche usuali utilizzate per la riproduzione e la selezione.
Il concetto di biosicurezza, applicato al Protocollo di Cartagena, si fonda sul “Principio dell’approccio precauzionale” dove la mancanza di certezza scientifica non deve essere usata come uno strumento che arresta l’azione quando c’è il rischio di un danno serio o irreversibile. Il Principio 15 della Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo (Rio de Janeiro, Brasile, giugno 1992) sostiene che “per proteggere l’ambiente, l’approccio precauzionale dovrebbe essere ampiamente applicato dagli stati, in base alle loro possibilità. Ove vi sia il pericolo del verificarsi di un danno grave o irreversibile, la mancanza di piena certezza scientifica non dovrebbe costituire una ragione per posticipare misure basate sull’efficacia dei costi che siano atte a prevenire un degrado ambientale.” Il principio di precauzione dovrebbe quindi essere lo strumento che orienta la ricerca.
62 nazioni hanno firmato il Protocollo di Cartagena sulla Bio-sicurezza a Nairobi
L'accordo stabilisce: l'obbligo di etichettare come geneticamente modificati tutti i prodotti che contengono o sono stati preparati con OGM, l'obbligo da parte degli esportatori di informare in anticipo se i prodotti contengono OGM e il diritto da parte degli importatori di rifiutare tali prodotti. Ci vorranno ancora anni prima di eliminare la passività di alcune nazioni alle forti pressioni delle grandi compagnie produttrici ed esportatrici.
La legislazione della UE
 |
La legislazione della UE tutela la salute dei cittadini e l'ambiente dagli eventuali rischi connessi con la coltivazione e la commercializzazione di prodotti geneticamente modificati.
La legislazione UE sugli organismi geneticamente modificati (OGM) è in vigore fin dai primi anni ‘90 e tale quadro giuridico è stato via via sottoposto ad ampliamenti e miglioramenti. |
La legislazione specifica è finalizzata a tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente dando vita nel contempo a un mercato unificato per la biotecnologia. Una parte significativa della legislazione UE in materia di OGM comprende l'emissione di organismi geneticamente modificati nell'ambiente. Nel 2002 è stato avviato un processo di approvazione per l'emissione nell'ambiente o l'immissione sul mercato di qualsiasi OGM o di prodotti contenenti OGM o costituiti da essi.
Qualche esempio delle disposizioni contenute nel quadro giuridico:
- valutazione dei rischi per l'ambiente e la salute umana costituiti dalla coltivazione o dall'immissione sul mercato di OGM;
- esigenze di monitoraggio successivo alla commercializzazione, comprensivo degli effetti a lungo termine connessi all'interazione con altri OGM e l'ambiente;
- obbligo di informare il pubblico;
- obbligo per gli Stati membri di assicurare l'etichettatura e la tracciabilità in ogni fase dell'immissione sul mercato;
- periodi di prima autorizzazione di immissione di OGM limitati ad un massimo di 10 anni;
- obbligo di consultare il-i comitato-i scientifico-i;
- obbligo di consultare il Parlamento europeo in merito a decisioni di autorizzare l'immissione di OGM.
Da quando è entrata in vigore, nei primi anni Novanta, la legislazione sugli OGM, nella UE è stata autorizzata l'immissione in commercio di 18 OGM. A partire dall'ottobre 1998, tuttavia, non è stata concessa nessun'altra autorizzazione.
Il 2 luglio 2003 un ulteriore passo in avanti per i consumatori: il Parlamento Europeo ha adottato le misure più rigide sull'etichettatura degli OGM in chiave mondiale. Un primo esempio di resistenza dell'Unione Europea nei confronti dell'intensa campagna globale del governo USA e dell'industria biotecnologica per minare e abolire le restrizioni verso gli OGM.
Le nuove misure dell'Unione Europea danno ai consumatori il diritto di rifiutare cibi OGM. Tutti gli alimenti ed anche i mangimi animali contenenti o derivanti da OGM, oltre la soglia dello 0.9%, dovranno essere chiaramente etichettati, rendendo possibile ai produttori e ai consumatori di continuare ad evitare il loro utilizzo.
La normativa in materia di OGM è attualmente in fase di riesame.
Legislazione
europea
Normativa Italiana
La legislazione italiana di riferimento (Decreti Legislativi n. 91/93 e n. 92/93) individua nel Ministero della Sanità l'autorità competente in materia di Organismi geneticamente Modificati. Presso il Ministero della Sanità sono state nominate:
a) La Commissione Interministeriale di Coordinamento per quanto riguarda l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 91/93;
b) La Commissione Interministeriale per le Biotecnologie per quanto riguarda l'emissione deliberata degli O.G.M. nell'ambiente a scopo di ricerca. Il decreto Legislativo n. 92/93 regolamenta anche l'immissione sul mercato di prodotti contenenti O.G.M.
Va posto rilievo sulla cosiddetta clausola di salvaguardia, prevista dall'art. 16 del Decreto Legislativo 92/93, la quale stabilisce che il Ministro della Sanità o il Ministro dell'Ambiente possono disporre di limitare o impedire provvisoriamente l'uso e/o la vendita di prodotti che siano ritenuti pericolosi per la salute umana o per l'ambiente.
Con un decreto legge del 2004 (divenuto Legge n.5/2005) l'allora ministro Alemanno ha cercato di afforontare anche il tema della coesistenza tra coltivazioni convenzionali, biologiche e OGM. L'impianto prevedeva la parità di diritti tra i diversi tipi di agricoltura, ma nei fatti imponeva forti limitazioni alla coltivazione di OGM con lo scopo dichiarato di proteggere le colture tradizionali e biologiche dalla possibilità di commistione con colture geneticamente modificate. Tuttavia, dopo una indagine avviata da un ricorso da parte della Regione Marche, il decreto è stato dichiarato incostituzionale in quanto il tema della coesistenza delle colture è di competenza delle Regioni.
In futuro pertanto le norme di coesistenza potranno variare significativamente da regione a regione infatti, nonostante nessuna regione possa vietare la coltivazione di OGM poiché contravverrebbe alla normativa Europea, l’imposizione di norme di coesistenza piu’ o meno rigide potrebbe rendere difficile l’instaurarsi di colture transgeniche sul territorio. Al momento 13 regioni hanno comunque predisposto delle norme che di fatto impediscono la coltivazione di OGM sul loro territorio.
Va notato comunque che, anche se attualmente non ci sono colture OGM in Italia (se non a livello sperimentale), non significa che sia un Paese “OGM free”. Infatti la gran parte dei mangimi utilizzati negli allevamenti italiani (esclusi gli allevamenti biologici) è prodotta a partire da soia e mais geneticamente modificati importati da Stati Uniti, Canada e America Latina.
L'Italia infatti produce solo l'8% della soia di cui necessita. La Campania, come la maggior parte
delle altre regioni, per adesso si attiene a alla legge Italiana
senza promulgare altri decreti propri.
Legislazione
ita
|