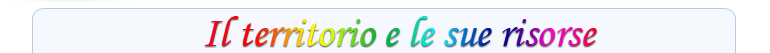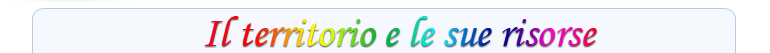Storia degli OGM
|
L’idea di manipolare esseri viventi è molto antica. Il primo allevatore che incrociò il miglior toro del branco con la migliore vacca per migliorare la razza, anziché lasciare che gli animali si accoppiassero a caso, stava utilizzando una forma rudimentale di biotecnologia. Analogamente, il primo fornaio che utilizzò gli enzimi del lievito per far lievitare il pane stava utilizzando un organismo vivente per migliorare un prodotto. L’unico aspetto che queste tecniche tradizionali avevano in comune era l’uso di processi naturali per modificare animali o cibi. Il primo OGM fu ottenuto nel 1973 da Stanley Cohen e Herbert Boyer. |
I primi organismi transgenici o ogm che l’uomo manipolò e furono dei batteri; la tecnica fu estesa quindi a colture in vitro di cellule di mammiferi, molte delle quali, però, non riuscivano a sopravvivere per lunghi periodi di tempo. Il passo successivo fu quello di inoculare geni estranei entro embrioni, in modo da ottenere interi organismi transgenici. Il primo successo fu quello dei biologi statunitensi Ralph L. Brinster e Richard Palmiter che, nel 1982, introdussero il gene dell’ormone della crescita prelevato da un ratto in embrioni di topo, e ottennero topi di dimensioni analoghe a quelle dei ratti, denominati super-topi.
La biotecnologia si sviluppò rapidamente fino ad arrivare a quella moderna che sfrutta organismi viventi per creare o modificare dei prodotti. Ma a differenza dei metodi tradizionali, permette di modificare in maniera diretta e precisa il materiale genetico degli organismi. Rende possibile trasferire geni da un organismo a un altro completamente diverso, consentendo combinazioni che sarebbero impossibili con i mezzi convenzionali. Ora i coltivatori possono prendere determinate caratteristiche da certi organismi e inserirle nel genoma di una pianta: possono prendere, ad esempio, la resistenza al gelo da certi pesci, la resistenza alle malattie da certi virus, e la resistenza agli insetti da batteri che vivono nel suolo.
|
Gli ogm oggi hanno trovato molti campi in cui svilupparsi, sono utilizzati nell'ambito dell'agricoltura, dell'alimentazione, della salute, dell'industria e della ricerca. Mentre le piante transgeniche sono impiegate su vaste superfici al di fuori dell'Europa, molte delle applicazioni presentate dai media negli altri ambiti restano delle potenzialità del campo della ricerca che suscitano un interesse commerciale o pratico ancora da mettere in opera. |
Del regno dei procarioti fanno parte tutti i batteri, anche essi legati agli ogm. Per inserire nuovi frammenti di DNA negli organismi si usano dei "vettori". I vettori sono generalmente piccole molecole circolari di DNA, i plasmidi, o strutture derivate da virus in grado di immagazzinare materiale genetico. Sono tre i processi attraverso cui è possibile modificare il genoma batterico.
- La trasformazione batterica è un processo naturale, attraverso il quale alcuni procarioti (detti competenti) sono in grado di ricevere del DNA esterno in grado di produrre nuove caratteristiche di fenotipo. Questo fenomeno fu scoperto nel 1928 da Frederick Griffith ma venne confermato solo nel 1944. La biologia molecolare si è servita dei batteri naturalmente competenti per comprendere a fondo il problema. Oggi sono state sviluppate alcune tecniche, per quanto molto empiriche, in grado di rendere competenti anche batteri che non lo sono naturalmente. È stato dimostrato, infatti, che l'ingresso di DNA è ampiamente facilitato dalla presenza di certi cationi, come Ca2+, o dall'applicazione di una corrente elettrica (tecnica detta della elettroporazione). I vettori utilizzati nelle trasformazioni sono essenzialmente plasmidi: in seguito all'ingresso, i plasmidi non si integrano nel genoma, ma rimangono autonomi (in uno stato detto episomale).
- Nella coniugazione batterica, il DNA è trasferito da un batterio all'altro attraverso un pilum (concettualmente un tubo che può collegare per breve tempo i due batteri). Un plasmide può essere così traferito da un organismo all'altro. La coniugazione, molto frequente in natura, è poco sfruttata come tecnica di modificazione genetica.
- La trasduzione è infine l'inserimento di materiale genetico nel batterio attraverso un batteriofago. È possibile valutare in modo agevole la funzione di un gene nei batteri: i ricercatori a tale scopo sono soliti realizzare dei ceppi batterici knock out. Questi organismi presentano un cancellamento del DNA relativo al gene d'interesse: osservando le conseguenze sulla vita del batterio, è possibile identificare la funzione del gene stesso.
L'uso di knock out è molto diffuso, non solo per i procarioti. È possibile realizzare knock out, infatti, con numerosi organismi modello. Il gene responsabile della fibrosi cistica, ad esempio, è stato individuato in topi knock out: una volta individuato il presunto gene della fibrosi cistica (chiamato CFTR), i ricercatori hanno individuato l'omologo nel genoma murino, ne hanno fatto un knock out, cancellandolo completamente, quindi hanno individuato nel topo così ottenuto tutti i sintomi clinici della malattia.
Anche gli animali possono essere modificati geneticamente "in modo naturale" attraverso le infezioni virali. La modificazione genetica, in ogni caso, avviene solo se il virus penetra nella cellula bersaglio (senza risposta del sistema immunitario) ed il materiale genico virale penetra fino al nucleo di essa.
In alcuni casi, tali proprietà dei virus possono essere sfruttate dai ricercatori per progettare vettori (appunto di origine virale) in grado di modificare in modo controllato il genoma delle cellule animali. In terapia, questa proprietà ha aperto la strada alla gene therapy), che consentirebbe di sostituire frammenti di genoma mutato nei pazienti, agendo proprio sulle cellule adulte che hanno subito mutazioni. Le mutazioni prodotte dalla gene therapy sono dunque totalmente a carico della linea somatica e non di quella germinale
 |
Nella ricerca c'è invece un forte interesse a realizzare linee stabili di animali transgenici, in modo da ottenere modelli animali utili per lo studio di patologie umane. Gli animali utilizzati per la costruzione di modelli in vivo di malattie umane sono numerosissimi, ma i topi rimangono i più frequenti. Per ottenere una linea stabile di modificazione genetica (quindi, per definizione, un animale transgenico vero e proprio), occorre che la modifica sia a carico della linea germinale. Esistono diverse tecniche di transgenesi animale che permettono di ottenere linee stabilmente modificate, per quanto il problema generale di |
questi approcci sia la bassa efficienza ed il numero elevato di animali da utilizzare.
Una delle principali applicazioni pratiche degli organismi transgenici è l’ottenimento di proteine ad uso terapeutico, quali alcuni fattori di coagulazione da somministrare ai pazienti emofiliaci. Prima della messa a punto della tecnica per la creazione di organismi geneticamente modificati, l’estrazione di proteine veniva eseguita da fluidi corporei animali, come sangue, plasma, urine, o tessuti; ciò non garantiva, però, l’ottenimento di quantitativi sufficienti rispetto alle necessità; inoltre, il procedimento non era immune dal rischio che le sostanze estratte fossero contaminate da agenti patogeni. Inoltre, durante il processo di estrazione potevano verificarsi modificazioni delle sostanze stesse, che ne determinavano l’inattivazione e quindi, l’inefficacia. Dalla sintesi operata da organismi transgenici e controllata dai geni estranei di cui essi sono portatori, si ricavano invece quantità maggiori di sostanze e un elevato grado di sicurezza di impiego. Alcune specie di mammiferi transgenici, ad esempio, producono latte con caratteristiche particolari, come la presenza di lattoferrina per essere più simili al latte umano. Inoltre, alcune sostanze ottenute in vitro da batteri modificati con le tecniche dell’ingegneria genetica, sull’uomo non risultano efficaci, se non vengono sottoposte a ulteriori modificazioni, che possono avvenire solo nell’organismo dei vertebrati; l’impiego di organismi transgenici permette allora di ottenere composti efficaci.
La scorticatura su una radice generata da Agrobacterium tumefaciens.
La principale tecnica di modificazione genetica di piante è legata all'attitudine naturale del batterio Agrobacterium tumefaciens di infettare piante e causare una crescita paragonabile a quella tumorale presente negli animali, tale patologia è nota come "galla del colletto". A. tumefaciens è in grado di infettare la pianta trasferendo un plasmide che che è in grado di integrarsi nel genoma dell'ospite. Il plasmide contiene diversi geni che, una volta "letti" dalla pianta, generano la galla e producono nutrienti per il batterio consentendone la crescita. Diversi scienziati, a partire dalla seconda metà degli anni '60, hanno contribuito a comprendere il meccanismo e le condizioni attraverso cui tale plasmide viene trasferito ed integrato nel genoma della pianta: tra questi Jeff Schell, Marc Van Montagu, Georges Morel, Mary-Dell Chilton e Jacques Tempé. Grazie a tali scoperte, a partire dal 1983 è stato possibile trasfromare le conoscenze biologiche acquisite, in tecniche biotecnologiche e quindi sviluppare versioni del plasmide "disarmate", ovvero senza i geni che davano origine alla malattia, in cui erano invece presenti geni di interesse, permettendo così di produrre le prime piante transgeniche, oggi molto utilizzate per fini di ricerca o agricoli.
 |
Un altro processo largamente utilizzato per produrre piante OGM è il metodo biolistico (anche detto gene gun, particle gun), che permette di "sparare" microproiettili ricoperti di DNA all'interno delle cellule vegetali. Tale metodo è stato utilizzato, ad esempio, per la produzione del più comune cereale OGM, il Mon810.
|
Le tecniche biolistiche sono spesso utilizzate per piante monocotiledoni, mentre A.tumefaciens ed altri agrobatteri sono utilizzati per modificare dicotiledoni, sebbene nuove linee di questo batterio sono state recentemente usate anche per modificare i monocotiledoni.Queste tecniche si aggiungono a quelle, più empiriche, già sviluppate all'interno del millenario processo di "umanizzazione" delle piante di interesse agro-alimentare che oggi si trovano sulle nostre tavole: il loro patrimonio genetico ha infatti subito nel corso del tempo modifiche genetiche rilevanti con tecniche convenzionali (oppure, si potrebbe dire, biotecnologie classiche), che hanno dato origine alla stessa agricoltura: selezione artificiale o, più recentemente, l'induzione di mutazioni per mezzo di raggi X o raggi gamma.
Supponete che un agricoltore non voglia che le sue patate o le sue mele si anneriscano quando vengono tagliate o si ammaccano. I ricercatori vengono in suo aiuto eliminando il gene responsabile di questo annerimento e sostituendolo con una versione alterata che blocca l’annerimento. Oppure poniamo che un coltivatore voglia piantare le barbabietole prima del solito, così da avere un raccolto migliore. Normalmente non potrebbe farlo, perché il freddo le farebbe gelare. Ecco che entra in gioco la biotecnologia, che trapianta nelle barbabietole geni provenienti da pesci in grado di sopravvivere tranquillamente in acque gelide. Il risultato è una barbabietola transgenica con una tolleranza al freddo doppia rispetto alla norma, in grado di resistere fino a 6,5°C sotto zero |