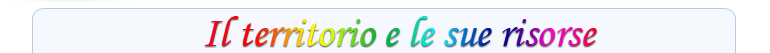Itinerario lungo il fiume Sarno
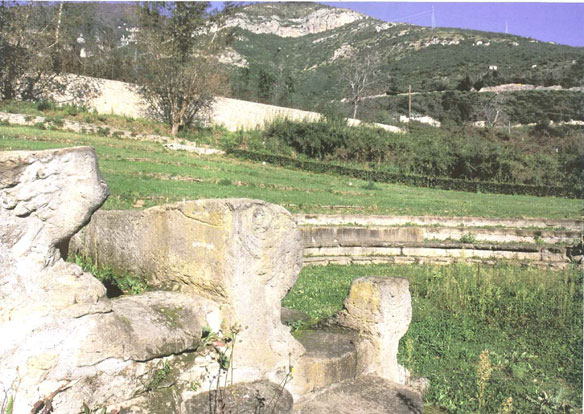
Tranquillo
Gaio Svetonio, ci racconta in un libro dedicato ai più famosi
retori di Roma, della presunta ascendenza divina di Marco Epidio,
maestro di Marco Antonio e di Ottaviano Augusto. Il trisavolo Epidio
noverino (o Nuncino?), precipitato a suo dire, nella fonte del fiume
Sarno, poco dopo ne riemerse invisibile e cornuto: divinizzato,
pertanto! Tra le sorgenti che ancora costituiscono il nucleo principale
del fiume Rio Santa Marina, Palazzo e Foce, è quest’ultima
che preserva il fascino, la suggestione dell’incanto e forse
del miracoloso evento nonostante le sue acque da un tempo non remoto
siano state captate.
Intorno ad essa, sono state ritrovate le più antiche testimonianze
antropiche (seconda metà del IV millennio a.C.) e di cultura
materiale, riconducibili ad un momento avanzato del Neolitico Medio
e di quello Finale. Sulla medesima area, in età ellenistica,
sorse un complesso sacro-architettonico, a testimonianza di culti
e rituali mai interrotti.
Esattamente qui, nei primi anni Sessanta del XX secolo, nel corso
di "traumatici sbancamenti edificatori" venne alla luce
un teatrino, edificato intorno al II secolo a.C; era parte integrante
del santuario, dedicato forse al Sarno, deus dei confederati nocerini,
o più verosimilmente, ad una divinità ctonia. L'edificio
scenico, piccolo gioiello d'architettura, è addossato al
dolce declivio della collina. Le inconfondibili nuances giallo ambrate
della pietra calcarea locale si confondono con il tufo grigio nocerino,
caratterizzato dagli intensi riflessi blu oltremarino degli eleganti
sedili della proedria, la zona dove prendevano posto le massime
autorità cittadine. La raffinatezza è sottolineata
dalle spalliere, raccordate ai sedili dell’ima cavea, mediante
braccioli a guisa di sfingi e di zampa leonina.
Dell'area sacra faceva parte anche un tempio non ancora individuato
e forse da ricercare alle sue spalle, considerando che tutto il
complesso si atteneva a schemi struttivi, ben noti in ambito ellenistico-romano,
ad esempio a Tivoli o a Palestrina. E’ possibile ammirare,
al momento, le eleganti statuine votive femminili e gli altri ex
voto fittili, rinvenuti in loco. Non sono più capaci, purtroppo,
decontestualizzati, di ridare al luogo ed alle sue acque lustrali,
quella arcana congiunzione con la divinità tipica dei santuari
antichi.
Se la dimensione ancestrale del deus loci ci è ignota, resta
la visione, a tutto campo, salendo sul punto più alto dello
scenografico terrazzo, sopra la cavea, della straordinaria pianura,
solcata dal grande fiume, fino al punto in cui si congiunge al Tirreno,
di fronte all'isolotto di Rovigliano.
Poco lontano, sempre a Foce, si intravede un ampio tratto del monumentale
acquedotto d'epoca augustea, edificato in forma di ponte-canale
in laterizio, adornato da nicchioni absidati. In località
Garitta, verso Palma Campania, all’ interno di una vasta necropoli
antica, è venuta alla luce, tra le altre, una stupefacente
tomba a cassa, costituita da lastre di tufo, dipinte, definita "del
guerriero", in considerazione del tema iconografico raffigurato
sulle pareti.
Come ha precisato l'archeologa Laura Rota, scopritrice della sepoltura,
è inquadrabile entro il IV secolo a.C. ed appartiene ad un
esponente dell'élite sannitica che ha dominato su un'estesa
area della Campania antica.

Oltre la vivacità delle accese cromie dal giallo al turchese,
al rosso sanguigno delle gote dei personaggi raffigurati a colpire
sono l'ingenuità e l'immediatezza compositiva.
II racconto procede, sulle quattro lastre dipinte, per sequenze
diacroniche. Alla scena del ritorno di un cavaliere di giovane età,
dalla chioma scura, si alterna, sulla parete di fronte, una donna
coronata, dai tratti alteri, assisa su un carro: due uomini la precedono
a formare il corteo funebre; l'uno è retrospiciente, l'altro
sostiene la coda del cavallo di un ulteriore guerriero, avanzato
negli anni, (con molta probabilità, il defunto, nel momento
estremo del trapasso), posto sulla lastra più breve. Sul
versante opposto, una ghirlanda. E, tra le figure, melograni, simboli
naturali e sacri della continuità della vita: l'unità
che contiene il molteplice.
Attualmente, la tomba e tutto il corredo sono in fase di restauro,
per trovare, successivamente, una nuova collocazio-ne a Palazzo
Capua, nel centro storico del paese. Stupendo edificio settecentesco
ospiterà il Museo della Valle del Sarno. Presto saranno esposti
i manufatti della cultura materiale delle 1500 e più tombe,
finora rinvenute, tra Sarno, San Valentino Torio
e San Marzano.
Seguendo il lento deflusso delle acque del fiume, verso la valle
che porta il suo nome, e lungo le sponde, si insediarono i primi
abitanti (i Sarrasti della tradizione remota). Lo scrittore romano
Servio, nel descriverli, si basa su quanto Conone, un suo predecessore,
aveva riferito: "... Alcuni Pelasgi ed altri usciti dal Peloponneso
giunsero in quel luogo d'Italia, che non aveva alcun nome prima,
e diedero il nome di Sarno al fiume presso il quale abitarono, dalla
denominazione della loro patria, e chiamarono se stessi Sarrasti...".
Mitici o reali, lottarono e convissero con due grandi forze della
natura, il Vesuvio ed il Sarno, senza soluzione di continuità,
nonostante a fasi alterne, si siano inurbati in piccoli o grandi
centri, Nuceria ad esempio, in posizione più centrale, nella
grande pianura. Rinvenimenti di resti di capanne dell'età
del bronzo a Poggiomarino, nei pressi del fiume, testimoniano la
specularità della vita rispetto al culto del defunto, abbondantemente
attestato in tutti i centri sorti sulle sue rive.
San Valentino Torio,
per usare le parole di Marisa de' Spagnolis, "... ha topograficamente
l'aspetto di un ventaglio aperto, la cui base è costituita
dal tracciato del Fosso Imperatore, affluente del Sarno e la cui
parte curvilinea è formata dal percorso del celebre fiume
nella sua parte iniziale. Questa configurazione geografica doveva
esistere anche anticamente e, pertanto... aveva la caratteristica
di essere completamente delimitato da corsi d'acqua".
II territorio è contraddistinto da grandi necropoli riconducibili
alla "cultura delle tombe a fossa". Si inquadrano cro-nologicamente,
tra il IX ed il VI secolo a.C. relative cioè all'età
del Ferro, al periodo orientalizzante ed all'epoca arcaica. Le più
antiche deposizioni (metà IX-primo quarto VIII secolo a.C.)
evidenziano corredi talora uniformi sia per la sfera femminile che
maschile. In queste ultime compaiono, nelle più sontuose,
armi, fibule di bronzo, askoi, tazze, scodelle monoansate ed olle
fittili, mentre si differenziano, nel periodo successivo, le deposizioni
femminili, caratterizzate da oggetti legati all'ornamento personale
ed alle attività muliebri.
Le tombe arcaiche denotano la comparsa dei vasi di bucchero e la
presenza di ceramica di produzione locale, con un'enorme ricchezza
di reperti metallici. Due altari in muratura, eretti l'uno accanto
all'altro, in campagna, recentemente scoperti, costituiscono una
importantissima testimonianza d'epoca romana. Sono pertinenti, con
molta probabilità ad un luogo di culto, interrato dall'attività
eruttiva del 79 d.C. Interessanti sono altresì, i resti di
una villa rustica, impiantata nel corso del I secolo a.C. Ampliata
successivamente all'eruzione vesuviana che seppellì Pompei,
Ercolano, Oplonti etc., fu ancora attiva a lungo.
II Fosso Imperatore, separa
San Valentino Torio da San Marzano che ad occidente,
è attraversata dal Sarno. Proseguendo tra le cannucce palustri,
i salici e le tife, che, tenaci, resistono lungo i bordi, si incontrano
le gallinelle d'acqua e le folaghe, insieme a domestiche anatre.
Questi ultimi radi (remoti?) angoli costituiscono la spinta e la
sfida a ridare al fiume l'identità a lungo negata. L'istituzione
del Parco Regionale del Fiume Sarno costituisce il passo preliminare
per il processo di "sviluppo della risorsa ambiente",
uno dei progetti strategici di primo piano del Patto Territoriale
per l'Occupazione delI'Agro Nocerino Sarnese.
Esattamente a San Marzano è stato individuato parte di un
argine antico del fiume, sepolto dall'eruzione si è delimitato
ad oriente, un ulteriore tratto del tracciato, di epoca romana.
Almeno fino a Scafati, come dimostrato dai rinvenimenti che attestano
la presenza del Pons Sarni, il fiume ha man-tenuto inalterati per
molto tempo il corso e l'assetto. Mutata la portata d'acqua, da
tempo non è più navigabile. Eppure il geografo greco
Strabone, a proposito di Pompei, la ricorda "... presso il
fiume Sarno che accetta e spedisce merci...".
Restano gli affreschi della Casa del Larario del Sarno a mostrare
una barca colma di derrate, tirata innanzi da due asini, mentre
il fiume, nelle spoglie di un dio, profonde acqua da un'anfora.
Ebbene, esso ha regolato, anche a San Marzano, come in tutti i centri
della piana, il ciclo vitale, testimoniato dalle necropoli rinvenute
nel territorio. Fossakultur anche qui.
Un repertorio ceramico però, più modesto. Consta di
poche forme reiterate, associate spesso ad imitazioni di prodotti
greci ed inoltre, a vaghi di collane d'ambra, di faience e di pasta
vitrea.
Nelle vetrine dell'Antiquarium, annesso al Palazzo di Città,
sobrio edificio della seconda meta del XIX secolo, erano esposte,
fino a qualche tempo fa, ancorette pissidi, provenienti da alcune
deposizioni scavate negli ultimi anni.
Più a valle , a Scafati, il Sarno lambirà, secoli
dopo la protostoria, ville rustiche di grandi estensioni che facevano
parte del suburbio orientale di Pompei, connotando fino ai giorni
nostri la vocazione prettamente agricola di tutta la Valle. Nella
feracità della terra e nella coltura del pomodoro, all’inizio
del Novecento vi è stato nuovo impulso economico con la creazione
di un polo conserviero tuttora elemento portante di sviluppo.
Dove oggi insiste il moderno centro cittadino venne costruito in
età antica, il Pons Sarni, situato sulla Nuceria-Pompeios,
la grande arteria viaria tra le due famose città dell’antichità.
|