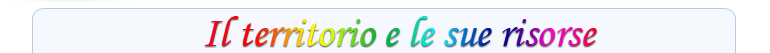Itinerario lungo sulle tracce della via popilia, tra eremi
e castelli

Lungo il crinale meridionale del
monte Sant'Apollinare, sopra il tunnel dell'autostrada che collega
Caserta a Salerno, una cesura netta nella nuda roccia è quanto
resta del percorso di una strada antica, la via Popilia: l'importante
arteria romana tracciata intorno al II secolo a.C. per facilitare
i collegamenti tra i centri economici di Capua, Nuceria Alfaterna
e la Calabria. II locus, definito da tempo immemorabile, Passo dell'Orco,
oggi negletto ed abbandonato, costituisce l'ideale punto di partenza
alla scoperta dell 'Apudmontem, ovvero le terre della media Valle
del Sarno, circondata dalla corona dei monti intorno ai comuni di
Castel San Giorgio, Roccapiemonte e Siano.
Al centro, svetta il Solano, "...un monte a forma di pan di
zucchero, (...) sormontato dal castello di Materdomini", così,
lo aveva apostrofato, a metà Ottocento, l'anonima viaggiatrice
inglese del nostro primo itinerario. Sul costone destro del Passo
si erge un monumento funerario, databile al I secolo a.C. ritenuto
a lungo una torretta d'avvistamento, per scrutare nell'antichità,
l'arrivo di incursori.
Muovendoci da qui, tenteremo un' escursione diversa, dopo vie di
terra ed un percorso fluviale, useremo stavolta un cavallo ed i
piedi, "...il mezzo più semplice ed il più economico".
L'11 settembre del 1847, lo scrittore e paesaggista Edward Lear
annota nel diario: "In treno raggiungemmo Nocera da dove, al
prezzo di due ducati, prendiamo una 'caratella' che ci porti ad
Avellino, capoluogo del Principato Citeriore (...). Quanti pochi
luoghi si possono scegliere sulla carta d'Italia e restare, tuttavia,
sorpresi di trovarvi bellezza e interesse!". Da Avellino, Lear
proseguirà il viaggio verso la Basilicata, a piedi, in compagnia
di Lord John Proby - sottolinea Vincenzo Pepe, nell'eccellente versione
italiana del testo - ed un unico cavallo per trasportare il bagaglio.
II loro viaggio durò poco meno di due mesi, ripresero il
treno di nuovo a Nocera il 4 ottobre dello stesso anno.
Niente paura, la nostra cavalcata/passeggiata
sarà più breve, tra palazzi, chiese, eremi e castelli.
Scendendo a valle, la presenza dei ruderi di ville rustiche, in
località Cappella di Paterno, poste ai limiti dei comuni
di Sarno e Castel San Giorgio, conferma la grande
vocazione agricola del sito, testimoniata dallo stupendo palazzo
barocco dei baroni de' Conciliis, una sorta di masseria fortificata.
Altri resti significativi appartengono all'acquedotto augusteo.
Attraversa buona parte di Castel San Giorgio, facendo affluire l'acqua
dalla sorgente Pelosi del Serino a Puteoli ed a Misenum. Le sue
tracce sono visibili in più punti a Paterno dove blocchi
di tufo grigio ricoprono gli sfiatatoi d'ispezione. Avanzi di un
santuario extraurbano, forse d'epoca ellenistica, si intravedono
sulla sommità di Sant'Apollinare, dove, intorno al 760, il
principe Arechi fece edificare la fortificazione di Santa Maria
a Castello, un'autentica barriera difensiva contro i Saraceni. Secondo
lo studioso Federico Cordelia, avendoli assoldati i duchi di Napoli,
durante la guerra ai principi salernitani, verso la fine del IX
secolo avevano invaso questi monti con frequenti e terribili incursioni.
Persa, ben presto, la vocazione militare, il complesso fu trasformato
in eremo e la chiesa palatina fu posta sotto la giurisdizione del
vicino Convento di Materdomini. L'ascesa all'eremo allarga l'orizzonte,
fino al baluardo del monte Liberatore di Cava de' Tirreni, a meridione,
per aprirlo al golfo di Salerno e, ad occidente, al sinus eccentrico
di Napoli, dove, incontrastato e pittoresco, domina lo sterminator
Vesevo.
A nord est, sulla cima della collina Montecastello, vi è
quel che resta del mastio di Castel San Giorgio, appartenuto già
nel 1087 a Roberto, figlio di Torgisio de Cripta. Sono gli anni
in cui cominciano a comparire, in questi luoghi, i castelli che
ne connotano le aguzze vette dei monti, determinando per tutto il
medioevo la storia e le sorti della valle posta al centro. Tre cinte
murarie, feritoie e torrette quadrate difesero il luogo fino all’eta
aragonese, quando la costruzione di una torre tonda e strutture
nuove, rappresentarono l'adeguamento della fortificazione a tecniche
militari più sofisticate e moderne.
Alle pendici della collina, si incontrano numerosi palazzi nobiliari
che hanno utilizzato il declivio naturale per impiantare, sui piani
terrazzati, giardini ed agrumeti. E’ il caso di Palazzo Calvanese,
da poco restituito alla collettività grazie ad oculati restauri,
che sfruttando tale posizione fu fornito di un particolare impianto
a caduta per l'irrigazione del giardino.
Se la teoria di finestre e balconi, lungo la facciata, ha perso
l'andamento sinuoso e mosso delle decorazioni barocche della struttura
antica, tuttavia, il giardino posteriore, cui si accede attraverso
una piccola corte interna, conserva il disegno originario, calligrafico
e romantico.
Assiale è la minuta fontana, sistemata in una prospettiva
gradiente, da cui si dipartono balze, ricolme di aromatiche essenze,
tra finte rovine classiche -autentiche quinte architettoniche- e
l'intrico di piccole scale asimmetriche, verso arcadiche costruzioni
merlate, dalle ampie aperture ad archi a sesto acuto. Due leoni
marmorei, a guardia di un ripidissimo vialetto, immettono al bosco,
verso ulteriori sentieri, più riparati e segreti.
Siamo a Lanzara, piccola frazione dell'esteso comune. L'elegante
borgo ha conservato, nelle dimore settecentesche, spesso non violate
da superfetazioni edilizie, tra cui spicca Palazzo Lanzara, quell'
aura di aristocratico distacco che ancor oggi avvertiamo nelle sue
strade e nella discrezione o nella grandiosità dei palazzi.
Proseguiamo, stavolta ad oriente, percorrendo la strada per Siano,
alla ricerca di un "imponente dipinto, con sovrapposta cimasa
raffigurante l'Eterno Padre", posto nella Chiesa della Congrega
del Salvatore, ad Aiello, altro nucleo abitativo di Castel San Giorgio.
Qui, nel piccolo complesso, arroccato su un altro rilievo, entro
una magnifica cornice dorata, campeggia la Madonna di Loreto, tra
uno stuolo di figure angeliche, San Sebastiano carnale e drammaticamente
umano, ancorato ad un tronco e San Rocco sul lato destro, con il
fido cane accanto. L'opera datata al 1588, è attribuita al
pittore napoletano Leonardo Castellano, attivo durante ed oltre
la meta del XVI secolo. II dipinto, meritevole di un urgente ed
accurato restauro, è stato accostato dalla critica, al disegno
preparatorio della Madonna di Loreto ed Adorazione dei Pastori conservato
alla Windsor Royal Library di Londra. Ricorda Carmine Zarra, in
un interessante lavoro sulla produzione pittorica del Cinquecento
nell'Agro Nocerino, che "Secondo la tradizione, documentata
a partire dal 1472, questo luogo santo sarebbe sfuggito alla distruzione
dei Saraceni, grazie agli angeli, che lo trasportarono fino a Loreto.
La Santa Casa diveniva così meta di un pellegrinaggio sempre
più intenso".
Poco lontano, verso settentrione, ci immettiamo nella bella valle
di Siano che "...si
presenta allo sguardo con il fascino del verde intenso dei suoi
folti castagneti e dei nocciuoli". La definizione data da Ottavio
Caputo, nella Storiat del Ducato di Siano, è avvalorata dalla
cavalcata nel Bosco Borbone, tra roverelle e castagni, felci, ginestre
dei carbonai e mirti: un bosco ceduo attrezzato per la sosta piacevole,
tra i sentieri, al riparo della calura estiva, dove si impongono
i resti litici dei maestosi Regi Lagni Borbonici, le opere di ingegneria
idraulica atte a contenere le piene primaverili ed autunnali, salvando
in tal modo il paese sottostante da rovinose frane. Sul finire dell'inverno,
il sottobosco si tinge dei colori muschiati della terra: tra i ricci
non raccolti, spuntano anemoni silvestri, ciclamini e mughetti.
Più a valle, in primavera, gemmano i ciliegi, nei giardini
entro ed ai margini del centro storico dove, troviamo pregevoli
opere d'arte, nelle Chiese dei Santi Sebastiano e Rocco e dell'Annunziata.
Nella prima, dalla sobria facciata di gusto neoclassico, campeggia,
sull'altare maggiore, il dipinto del pittore napoletano Michelangelo
lannacci, eseguito nel 1794, con la Vergine in gloria tra i due
Santi patroni.
Spicca, inoltre, la personalità di Costantino Desiderio pittore
nativo di Angri che esegui nel 1794 quattro tele, di cui ne rimangono
due, recentemente restaurate: un Sant'Antonio da Padova con Madonna
e Bambino e la Madonna delle Grazie con le anime del Purgatorio.
L'opera d'arte però, più esemplare, per forza evocativa,
è l’affresco, distaccato e rimontato su tela, di Santa
Maria della Consolazione tra San Sebastiano e San Leonardo, proveniente
dalla cappellina ipogea dell'Annunziata e sistemato nell'attuale
cappella del Battesimo, all'interno della moderna ed omonima chiesa
parrocchiale. L'affresco faceva parte di una più vasta superficie
pittorica. Databile al pieno XV secolo, al momento non è
stato ancora indagato in maniera esaustiva, ma colpisce per la freschezza
compositiva e cromatica, nonostante talune ingenuità stilistiche.
Da Siano, costeggiando Castel San Giorgio, ci soffermiamo a Casali,
piccola frazione di Roccapiemonte,
dove nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie e conservata la Madonna
di Costantinopoli con i Santi Bartolomeo e Nicola di Bari, uno dei
capolavori di Angelo Solimena, databile intorno al 1671. Le fa da
contralto, una superba Madonna del Rosario, autentica pastiche settecentesca,
ricavata unendo le figure tratte da due opere di Francesco Solimena:
la omonima Madonna - forse in origine proveniente da Casali - confluita
nel 1971 alla Gemaldegallerie di Berlino e il San Michele del Duomo
di Sarno. Dunque, da qui, risaliamo i terrazzamenti della dorsale
collinare, alle cui pendici gli antichi hanno estratto per secoli
il prezioso tufo grigio dai riflessi argentei, verso il castello
sulla sommità del Solano. Costruito nel 1042 dal principe
di Salerno, Guaimario IV, fu risistemato in epoca angioina e dopo
varie vicissitudini, venduto, con tutto il feudo di Roccapiemonte
ad Antonio Ravaschieri, duca di Satriano poco dopo la meta del Seicento.
Rimangono ampie tracce delle tre cinte murarie ad andamento concentrico
che circondano la sommità del monte, resti della merlatura
e della porta escea. Testimoniano tuttora l'importanza strategica
avuta durante il Medioevo.
Di fronte, "appollaiato sulle falde di una massiccia muraglia
rocciosa denominata Caruso" si erge l'Eremo di Santa Maria
de la Fracta detto Santuario di Santa Maria di Loreto, fondato intorno
al XII secolo e rimaneggiato nel corso del tempo. II complesso è
ancora, scrive Mario Vassalluzzo, eminente storico dei luoghi, meta
di un devoto pellegrinaggio "sollievo per lo spirito affaticato
e per il corpo intristito dai miasmi dei centri abitati". A
valle, in posizione più arretrata rispetto al corso Mario
Pagano, autentico cuore pulsante dell'operosa cittadina, incontriamo
l'ultima tappa del nostra iti-nerario, la residenza dei Ravaschieri,
duca di Roccapiemonte.
Immersa tra lecci secolari, platani e palme, la villa dallo splendido
profilo neogotico, contrassegnato da grandi monofore e bifore, ha
perso lo smalto degli anni in cui la dimora costituiva il buen retiro
della potente famiglia. Restano solo i sarcofagi marmorei, all'interno
dell'annessa Cappella dell'Addolorata, progettata nella seconda
decade del Settecento dal celebre architetto Ferdinando Sanfelice,
a testimoniare passate e più auguste vicende. |