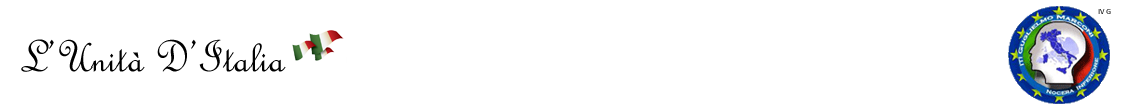
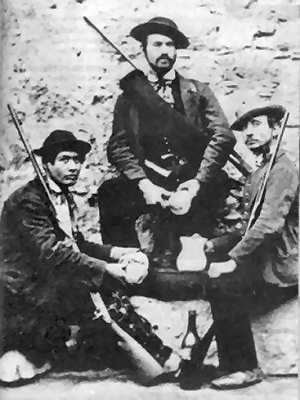
La storiografia risorgimentale riprese la definizione di brigantaggio usata dallo stesso governo del Regno d'Italia per mascherare agli occhi degli stati europei le gravi difficoltà della avvenuta unità. Successivamente gran parte degli storici ha inquadrato tale fenomeno come espressione di un disagio autentico, manifestatosi con le forme di una vera propria guerra civile (1861-1865). In realtà il brigantaggio era nato e prosperava nel Mezzogiorno ben prima dell'annessione al Regno d'Italia, ma si era sviluppato ulteriormente negli anni sessanta dell'Ottocento in seguito all'invio di un gran numero di reparti dell'esercito. Per altri studiosi, fra cui Benedetto Croce, il brigantaggio fu l'ultimo sostegno di una monarchia, quella borbonica, che ancora una volta aveva chiamato in suo aiuto «...o piuttosto a far le sue vendette, le rozze plebi, e non trovando altri campioni che truci e osceni briganti...». Che si trattasse di un fenomeno non solo criminale è dimostrato tuttavia dal fatto che si ritenne necessario l'intervento dell'esercito regio e l'emanazione di leggi speciali (la legge Pica 1863), che applicavano la legge marziale nei territori del Mezzogiorno italiano.
La ricerca storica più recente ha contribuito a mettere in luce gli aspetti politici che motivarono la resistenza delle popolazioni meridionali prima nei confronti dei Borbone, poi del Regno d'Italia (con le conseguenti repressioni), superando definitivamente il modello che ha tentato per decenni di liquidare l'insorgenza meridionale come fenomeno esclusivamente banditesco. La complessa problematica legata a tale resistenza non fu estranea (insieme ad altre concause) alla nascita della Questione meridionale.(definizione da enciclopedia) Ampio fenomeno misto di banditismo e di ribellione politico-sociale nelle campagne del Mezzogiorno. Fece seguito all'unificazione italiana che, con l'imposizione di misure amministrative e fiscali di particolare durezza, ivi comprese la completa abolizione dei secolari usi comuni (civici) delle terre a tutto vantaggio del latifondo, … dando esca, ...alla propaganda filoborbonica e clericale, ostile al nuovo stato liberale, a sua volta incapace di una politica che non fosse di pura repressione ... Le bande di briganti, che già costituivano un male endemico di quelle campagne, si ingrossarono rapidamente, raggiungendo le migliaia di unità e dando vita a episodi di violenza cieca e raccapricciante ma anche all'occupazione temporanea di interi e popolosi centri fino al rischio di unificarsi in un esercito insurrezionale. Contro di esse fu istituito lo stato di guerra (militarizzazione del territorio e pieni poteri legalizzati con la legge Pica nel 1863) affidato ai generali Enrico Cialdini prima e Alfonso La Marmora poi, al comando di 163.000 uomini (20.000 bersaglieri, cavalleria, fanti, 6.900 carabinieri e 84mila militi della guardia nazionale e civica), che eseguirono spietate rappresaglie facendo terra bruciata intorno alle bande per poi annientarle sul campo.
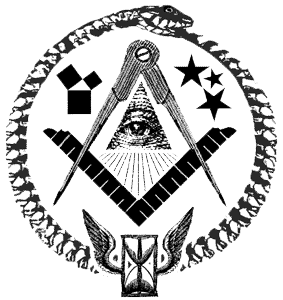
L’espugnazione di Gaeta decreta, se ce ne fosse ancora bisogno, la fine dei Borboni. Il nuovo status nazionale sta mettendo a nudo un'infinità di problemi: primo fra tutti la presenza di un nuovo stato e quindi di un nuovo ordine. Lo stato nazionale fatto di leggi, di diritti ma anche di doveri era per i più incomprensibile. Il clero ricco istigava nei poveri il concetto che lo stato fosse anticlericale (e lo aveva già ampiamente dimostrato), perché voleva la fine del papato e dei benefici della chiesa. Nel mezzogiorno e nelle isole le condizioni di vita, il livello dell'educazione e quello del reddito sono molto bassi, specialmente nelle zone interne scarsamente collegate. Ecco dunque un terreno ideale per la leggenda del fuorilegge, il brigante, il Robin Hood che ruba ai ricchi per dare ai poveri. Le bande che si costituiscono sono composte in parte da ex soldati borbonici, delinquenti evasi o liberati, e anche da poveri braccianti. Insieme formano bande di varie decine di persone, a volte migliaia, che assaltano e occupano città e comuni. In mancanza di comunicazioni, di un progetto e di una strategia la loro esistenza è a tempo. Francesco II e la moglie Sofia, scappati a Roma, fanno la loro parte con denaro e rifugio per chi varca i confini del papato. Di fronte al ramificarsi del fenomeno, il governo prende adeguate misure, già all'indomani dell'entrata a Napoli di Garibaldi. Lo stesso Garibaldi vi era stato costretto. Erano giunte notizie di bande che operavano nell'Abruzzo, poi in Calabria, ed infine nelle isole. Ventiquattro dei trentasei battaglioni bersaglieri a disposizione vengono dislocati nel Sud. Famosi capibanda furono Crocco, Nanco, il Generale spagnolo Borjes; ecco poi un marchese di Namur, Alberto de Trezegnes agli ordini del brigante Schiavone; Giacomo Giorgi nell'avellinese, i fratelli La Gala evasi da Nisida che si mangiarono un contadino chiacchierone, Tamburini nel Chietino, i fratelli Pomponio, il Tiburzi in Maremma e Musolino nell'impenetrabile Sila.
